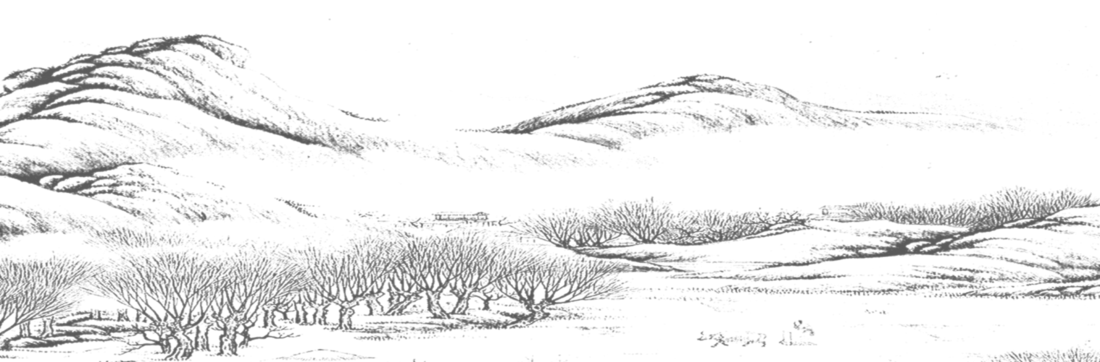L’ambiguità del paesaggio
In un articolo dal titolo emblematico “L’arguzia del paesaggio”, Farinelli ci ricorda che la parola “paesaggio” serve a designare allo stesso tempo la <cosa> e <l’immagine della cosa>. Da ciò si può desumere che il paesaggio ha una natura evidentemente ambigua, il che ha portato spesso a un uso viziato o equivoco del termine.
L’equivoco consiste nel fatto che si tende a mantenere su un piano di ‘uguaglianza’ due sensi che invece bisognerebbe prima distinguere, per poi cogliere meglio quell’ambiguità che fa apparire in questa separazione una più profonda inseparabilità. Questa ambiguità del paesaggio, infatti, non consente di soffermarci solo sulla cosa, su ciò che è esistente e tangibile (il paese o le componenti fisiche di un paesaggio), ma sposta continuamente la nostra sensibilità anche su ciò che è sussistente, su cosa si mostra o si mette in scena in un paesaggio (l’apparenza in atto). Ed è proprio in questo spostamento, in questo movimento, che si avverte il passaggio da ciò che si può toccare e vedere a ciò che ci ‘tocca’ e si può sentire, ovvero a tutto ciò che un paesaggio irradia in noi emotivamente.
Per questo motivo, si direbbe che in un paesaggio l’atto ‘percettivo’ non si dissocia mai dal momento ‘affettivo’, ovvero da quella capacità che una certa situazione ha di ‘toccarci’ sensibilmente in un dato momento. Ed è proprio in questo gioco di polarità o spostamenti che affiora il paesaggio, un affioramento che scaturisce dalla pregnanza costitutiva tra la sensibilità della ‘cosa’ e l’apparenza delle immagini. Quindi ciò che più propriamente dovremmo chiamare paesaggio è questo ‘affioramento’, che scaturisce dall’implicazione emotiva tra un soggetto e una situazione, tra un individuo e il suo mondo.
Un affioramento la cui espressione sensibile vincola le nostre emozioni a una certa situazione che avvertiamo come atmosfera o tonalità emotiva di un luogo, ovvero come la capacità affettiva di un paesaggio.